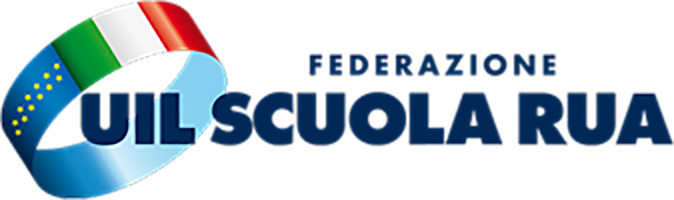L’I.A. nella scuola tra innovazioni metodologiche e nuovi linguaggi. (Trento 13/05/24). Massimo Di Menna
L’utilizzo di I.A. si sta diffondendo con grande rapidità.
Abbiamo delineato nel precedente incontro il percorso che ci sembra al momento più utile: conoscere l’I.A. per poterla “educare”, governare. E’ sempre valida l’affermazione di Wittgenstein “conoscere è saper usare”. Il percorso in 4 tappe che abbiamo delineato ha questa finalità conoscitiva.
Dovendo affrontare il tema di una metodologia adeguata nell’attività didattica, partirei da questa affermazione: non c’è un metodo unicamente valido; si possono fare diverse scelte metodologiche, in relazione alle tante variabili che compongono il processo educativo personalizzato. Il suggerimento metodologico che facciamo è semplicemente quello di evitare una separazione tra studio curriculare e conoscenza dell’I.A. Il processo va integrato. Si tratta di far entrare, al di là dell’utilizzo che se ne fa, l’I.A. nel curricolo. La problematica va affrontata in un laboratorio didattico dove convivono lezione, ricerca, documentazione, illustrazione. L’obiettivo è conoscere l’I.A. innalzando i livelli di istruzione e viceversa.

- Un primo intervento può riguardare la resistenza ai cambiamenti, e i grandi progressi connessi alle innovazioni tecniche, scientifiche. Questo tema, storico nella sua declinazione, risulta di particolare interesse e di attualità, proprio in relazione alle preoccupazioni e alle criticità connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e alla diffusione di I.A.I periodi storici da studiare sono diversi; in questo contesto sicuramente si può approfondire il periodo dell’Umanesimo, in particolare assume importanza lo sviluppo delle tipografie e la diffusione dei libri, con la cultura, il sapere che esce dai conventi; Venezia come realtà in primo piano in questo processo stimola interesse e curiosità.
Attraverso l’attenzione per le prime ricerche su I.A., che risalgono agli anni ’40 del secolo scorso, si può approfondire la macchina di Turing; la sinergia con il curricolo ci avvicina alla conoscenza dell’Europa nell’era dei nazionalismi, della seconda guerra mondiale, e via via come si sviluppa il processo di integrazione europea, con opportunità e limiti, soprattutto nell’attuale contesto geo/politico.
Conoscere l’I.A. studiando l’Europa può essere una idea che realizza il metodo di integrazione indicato.
La discussione intorno all’I.A. generativa, in particolare quella che genera immagini è occasione di studio e di approfondimento sul tema realtà effettiva e realtà generata che convivono: come distinguere, come garantire la provenienza, come regolamentare.
Riflettendo sulla storia del pensiero, si entra in una dimensione in cui cogliamo che il tema non è nuovo. Platone poneva il tema di riconoscibilità tra realtà ed imitazione. Kant, uno dei padri dell’era moderna, poneva il tema della differenza tra fenomeno (ciò che appare) e noumeno ciò che è). Hegel, uno dei filosofi che hanno influenzato tante teorie del’900, invitava a riflettere sulla definizione di realtà, come ciò che è razionale, e di razionalità, come ciò che è reale, sollecitando la ricerca dell’affermazione della razionalità, per eliminare il non reale.
Si tratta di temi che ovviamente vanno declinati in ragione dell’ordine di scuola.
- L’utilizzo di I.A. in diversi campi delle scienze è occasione di un percorso di studio integrato, in grado di far comprendere l’utilità della ricerca in campo di I.A. con la padronanza di ambiti scientifici di rilevante attualità.
L’Astronomia è settore in cui l’I. A. consente progressi in termini di visione di elementi altrimenti non percepibili, così come la Meteorologia attraverso un numero maggiore di informazioni statisticamente rilevanti ai fini delle previsioni, o più ancora la Biologia, nello studio delle molecole e delle proteine. In campo medico le applicazioni in materia di prevenzione e diagnosi,soprattutto nella lettura di lesioni altrimenti non percepibili.
Non è difficile studiare le Scienze e conoscere l’I.A.
A tal proposito suggerisco due video che illustrano bene, l’uno questa integrazione, l’altro come si genera la tecnologia conosciuta come I. A.
Il primo del prof. Marc Mézard, dell’Università Bocconi di Milano, reperibile su Rai cultura, il secondo del Prof. Gianluigi Greco dell’Università della Calabria, reperibile su youtube (una sua lezione in un istituto scolastico di Cosenza, di novembre2023).
- Discutendo sull’uso degli iphone, dei “telefonini”, si entra nella quotidianità: l’integrazione riguarda lo studio dell’Economia, l’Educazione finanziaria. La notizia di questi giorni è che Microsoft sta realizzando nuovi p.c., basati su I.A. generativa con strumenti integrati all’operativo Windows; ritiene di venderne in un anno 50 milioni.
Discutere sui grandi investimenti finanziari di Google, sull’accordo che cerca Apple per introdurre la nuova tecnologia I.A. negli iphone, aiuta a mettere in connessione investimenti/ricerca/ mercato e consente di studiare in sinergia i processi economici e finanziari, e conoscere l’I.A.
Si può passare a capire dove nasce la ricerca, Usa e Cina prevalentemente, quindi come si prospetta un mercato globale, e come sta cambiando la geo politica.
Di nuovo la riflessione riguarda l’Europa più che i singoli stati, e il limite connesso alla semplice realtà di consumo.
L’I.A. entra anche nella attività delle Banche centrali, per la maggiore tempestività e quantità di dati elaborati per le previsioni, fondamentali in macroeconomia, per la definizione dei tassi di interesse e delle connessioni con l’economia reale. In fondo siamo in presenza di un dato statistico molto più preciso, veloce e sofisticato. Si studia Economia e si conosce I.A. e viceversa.
- La regolamentazione nell’utilizzo di I.A., l’A.I. Act europeo.
Il documento europeo pone regole alle società informatiche, per evitare o ridurre rischi, nelle applicazioni possibili. Si tratta del primo ed unico documento a livello globale, che cerca di proteggere i cittadini europei da un uso indiscriminato. Alcuni utilizzi sono vietati, altri richiedono documentazioni ed autorizzazioni, altri ancora semplici segnalazioni, altri sono liberi. Sono previste sanzioni pecuniarie per le società inadempienti. E’ bene che questo documento venga conosciuto e discusso nelle scuole, e contestualmente determinare occasioni di studio su aspetti importanti, sul diritto comunitario, italiano, sul sistema costituzionale, dei diritti, della responsabilità, delle regole e delle sanzioni: fare Educazione civica conoscendo I.A. Si può passare al funzionamento della democrazia nella società digitale (o dei dati, come oggi alcuni sociologi la definiscono). Un percorso didattico può favorire la conoscenza dell’Europa e delle opportunità/criticità connesse all’I.A.
- Nuovi Linguaggi
L’attenzione ai nuovi linguaggi non è fatto nuovo connesso alla diffusione di I.A. Le nuove tecnologie hanno portato da tempo cambiamento nel linguaggio comune, professionale, tecnico, nella comunicazione. Sviluppare un laboratorio didattico sul Linguaggio consente di innalzare i livelli di conoscenza e di acquisire maggiore consapevolezza dei processi connessi ad I.A. generativa. Occorre partire da alcuni concetti chiave quali la parola come rappresentazione di un’idea, significato come collegamento con il contesto, con i toni, con il vissuto.
La molteplicità dei linguaggi e la forza simbolica connesse al linguaggio scritto, di immagini, poetico, settoriale, determinano le relazioni nelle Comunità, e fanno vivere nel Dialogo la complessità dei linguaggi stessi. Affrontare il tema del Linguaggio ci avvicina, nell’attività didattica, ad aspetti della Psicologia, a partire dallo studio dei processi mentali, spesso connessi alla interpretazione soggettiva della comunicazione.( fa testo il richiamo all’ interpretazione di un mancato invito ad una festa, che, producendo processi mentali soggettivi, determina interpretazioni, comportamenti in una serie di successive comunicazioni e relativi processi mentali, in cui la realtà “mentale” si sostituisce alla realtà effettiva, o ne genera di nuova).
Siamo spesso spinti ad entrare nel linguaggio dell’algoritmo, per entrare nel mondo della tecnologia, per padroneggiare visioni, fonti e strumenti comunicativi.
Il laboratorio didattico connesso a questa ricerca può partire dalla semplice considerazione che l’intelligenza non è pura capacità calcolante, ma è intuizione, immaginazione: è in questa area che si ricerca il confine tra intelligenza umana ed intelligenza artificiale. Si discute molto del rischio di manipolazione, ed è un bene che se ne discuta; occorre avere consapevolezza che anche per questo aspetto siamo di fronte all’evolversi di un processo già esistente. La differenza da considerare non è nuova: argomentare dialogando rispetto a convincere senza argomentare. A tal proposito suggerisco la visione/riflessione di due film. Il Postino, nel dialogo sulla poesia tra il postino Troisi ed il Poeta Neruda, Noiret “la poesia serve a chi la sente/legge non a chi la scrive”, e Fantozzi subisce ancora, in cui Fantozzi Villaggio viene travolto da immagini e parole perdendo l’orientamento, mentre segue una tribuna politica. Riflettere su come gestire il “ bombardamento comunicativo” odierno, già entrato nella quotidianità non solo della comunicazione, ma della nostra vita, se pensiamo al numero delle ore in cui siamo connessi ed al numero delle comunicazioni, brevi e di vario tipo con cui entriamo in contatto. Con l’I.A. generativa questo aspetto già esistente trova amplificazione con un sistema di interlocuzione (domanda/risposte, generazione di immagini e voci), con cui entriamo in contatto. E’ evidente l’importanza del sapere, dell’istruzione, della mente aperta e critica per governare l’insieme di questi nuovi linguaggi e di queste nuove modalità comunicative. Oggi la sfida tra le società che investono in I.A. è nel numero dei dati e nella quantità di addestramento per consentire risposte sempre più complete; si tratta ovviamente di dati reperiti dalla comunicazione umana. Lo studio, ed una didattica efficace servono per una sfida, altrettanto importante, quella dal basso, formativa per rafforzare il processo critico di comprensione.
A tal proposito suggerisco di riflettere su una recente affermazione del Direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana ,in una sua lectio brevis all’Università La Sapienza di Roma “ Le notizie ci arrivano ormai da un milione di punti diversi, giornali, tv, radio, video virali, motori di ricerca, notifiche nei cellulari, socialnetwork, blog, podcast, siti più o meno specializzati; siamo letteralmente bombardati, con una sovrabbondanza che genera qualche volta stordimento e difficoltà ad orientarsi”.
Ai nuovi linguaggi aggiungiamo quelli generati da I.A., che non è semplice pappagallo, come invece riteneva Turing.